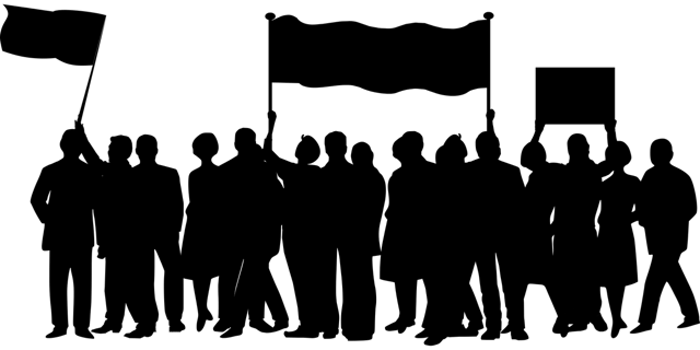Ho appena letto questi due articoli, il primo dell’amico Diego Melegari e di Fabrizio Capoccetti https://www.sinistrainrete.info/politica/17904-diego-melegari-e-fabrizio-capoccetti-i-bottegai-ultimo-argine-spunti-per-una-politica-oltre-purismo-e-subalternita.html?highlight=WyJkaWVnbyIsIm1lbGVnYXJpIiwiZGllZ28gbWVsZWdhcmkiXQ== e il secondo di Lorenzo Biondi https://www.lafionda.org/2020/06/04/ripensare-la-composizione-di-classe/?fbclid=IwAR1IjyL5aEVc1i8ECTJWch2vcHh0784bSeFckFmP8aiXtwY3zbobS_qFcks
Non condivido la loro tesi che è di fatto la stessa. Che cosa fanno, semplificando in estrema sintesi e se volete anche banalizzando (la comunicazione sui social impone purtroppo il ricorso a messaggi brevi, rapidi e molto semplici…) questi amici e compagni?
Tirando (molto…) per la giacchetta il Preve e soprattutto il Marx-pensiero, ci dicono che siccome ormai il proletariato è morto – nel senso che non esiste più nei termini e nelle forme storiche in cui lo stesso Marx lo ha conosciuto ed individuato come soggetto “ontologicamente” ed oggettivamente rivoluzionario e quel che ne resta è stato prima castrato e “imborghesito” dalla socialdemocrazia (questo loro non lo hanno scritto ma è nelle cose, ed è anche vero sotto un certo profilo) e poi spappolato (anche ideologicamente) dal liberalismo e dal neoliberalismo – bisogna cambiare completamente il soggetto di riferimento potenzialmente rivoluzionario (quel potenzialmente pesa come un macigno…) e forse “oggettivamente” rivoluzionario (pensano loro). E lo pensano perché, a loro parere, quel soggetto – che lo stessi chiamano “bottegai” (ma non con intento dispregiativo, anzi…) – cioè quel ceto di media borghesia di commercianti, professionisti, piccoli e medi imprenditori e artigiani – ha interessi radicalmente divergenti con quelli del grande capitale monopolistico e/o oligopolistico. Il che, naturalmente, è tutto da vedere, sia dal punto di vista oggettivo, cioè degli interessi economici, sia da quello ideologico (che ha il suo peso).
Innanzitutto bisogna fare dei distinguo, e cioè capire all’interno di questo ceto quali sono i soggetti che potrebbero avere interesse ad una alleanza “gramsciana” di classe con i lavoratori salariati e i ceti popolari e subalterni. E qui già la mano che, metaforicamente parlando, raccoglie la sabbia, nel momento in cui stringe il pugno ne perde parecchia. Una parte, anche rilevante, di piccoli e piccolissimi artigiani e commercianti hanno (il che non significa che sia scontato, significa che bisogna lavorarci…) o potrebbero avere l’interesse oggettivo ad una alleanza con i ceti popolari. Se questi ultimi si impoveriscono, infatti, anche loro potrebbero fare la stessa fine. Questo perché il rapporto del proprietario (o affittuario) del negozio di alimentari o di vini e oli (o di qualsiasi altra piccola attività commerciale) con la sua utenza (la gente del quartiere popolare o del rione dove molto spesso lui stesso risiede) è molto stretto, sotto ogni punto di vista. Questo piccolissimo e piccolo commerciante è già da tempo in conflitto con la grande distribuzione che gli sottrae la clientela. Aspira psicologicamente e ideologicamente a fare il salto di qualità ma è anche consapevole di non potercela fare. Per di più, come appunto già detto, è in parte legato alla sua utenza da una serie di vincoli non economici anche se, va sottolineato, il processo di “liquefazione” e atomizzazione sociale ha reso quei vincoli sempre più deboli. E però, nonostante ciò, questo “soggetto” possiede i “requisiti” sociali e culturali che potrebbero spingerlo alla costruzione di un grande blocco sociale con i lavoratori salariati, privati /e o pubblici, “garantiti” o precari. Lo stesso discorso vale per tutta una serie di altri soggetti; partite IVA finti lavoratori autonomi e finti imprenditori di fatto lavoratori parasubordinati, piccolissimi padroncini “fai da te”, taxisti, ecc. ecc.
Il lavoro che una forza socialista dovrebbe fare – se esistesse – dovrebbe essere proprio quello di separare tutta questa serie di soggetti deboli o relativamente deboli da quelli più forti, più solidi, più ricchi. Mi riferisco a quella parte di media borghesia composta da commercianti solidi, medi imprenditori e professionisti che invece non hanno alcun interesse ad una alleanza con i ceti popolari, sia dal punto di vista economico (oggettivo) sia dal punto di vista ideologico (che ha sempre il suo peso) e che non hanno nessun legame e nessun vincolo con i lavoratori salariati se non quello di essere i loro “datori di lavoro” (con tanto di plusvalore e pluslavoro, dal momento che sono stati tirati in ballo…). Ed è proprio questo che li pone oggettivamente dalla parte opposta della barricata, contrariamente a quello che pensano i nostri due amici.
Questi ceti sono intimamente e oggettivamente legati al grande capitale anche se la crisi (e ultimamente anche la crisi provocata dal coronavirus con le conseguenti misure di contenimento) li ha economicamente indeboliti. Ma questo indebolimento non li fa pendere dalla parte di chi sta in basso. Al contrario tendono a rafforzare i loro vincoli con chi sta ancora più in alto. Dalle stelle dell’analisi sociologica alle “stalle” (che sono sempre quelle che contano…) della prassi e della realtà concreta, sanno che dall’UE stanno per arrivare un bel po’ di quattrini e vogliono la loro fetta di torta. Nello stesso tempo vogliono far pagare i costi della crisi (e del loro relativo impoverimento) ai lavoratori e ai loro dipendenti, precarizzando ulteriormente il lavoro, abbassando i salari e aumentando la competizione fra i lavoratori stessi. La crisi diventa quindi lo strumento per rafforzare ancora di più la loro posizione, indebolire quella dei dipendenti e in ultimo, ma non per ultimo, ricattare di fatto lo stato e il governo che, non a caso, stanno attaccando duramente. La Lega e Fratelli d’Italia sono quelli che portano avanti l’attacco frontale, sotto questo profilo. Sono le forze che più di altre (anche Forza Italia anche se in termini più morbidi) rappresentano questa porzione di società. Il patto che propongono agli altri settori sociali (piccolissimi e piccoli commercianti e artigiani e lavoratori salariati) è tutto interno alla famosa logica dello “sgocciolamento” in base alla quale se il datore di lavoro è sempre più forte e sempre più ricco, le briciole o magari anche qualcosina di più piove anche su chi sta in basso. Ovvio che in una condizione di precarietà e di difficoltà, spesso grave, molti di questi, pur consapevoli di essere in una condizione di subalternità, potrebbero finire, obtorto collo, con più o meno convinzione, per sottoscrivere o sottomettersi a quel patto.
Mi pare che negli articoli succitati si commetta invece un errore molto grave, di natura ideologica. E cioè si sposta l’attenzione da un ceto sociale ad un altro nella speranza – mi permetto umilmente di dire è un approccio fondamentalmente soggettivista e poco marxista (non che sia una colpa, sia chiaro, non è un delitto non essere marxisti…) – di individuare il soggetto rivoluzionario. Si dichiara la fine del lavoro salariato come soggetto potenzialmente (ripeto, potenzialmente…) rivoluzionario perché si è rivelato storicamente incapace di essere classe dirigente, di essere classe in sé e per sé, come si suol dire, come se questo fosse un dato ormai storicamente acquisito una volta per tutte. Ma la realtà è dialettica e non statica. Non possiamo decidere che qualcosa è o non è, sulla base di ciò che è stato o di ciò che pensiamo potrebbe essere (che percentuale di falsa coscienza, magari anche in buonissima fede, e di opportunismo politico, sempre in buona fede, potrebbe esserci in questo modo di vedere?…) Il paradosso è un altro.
Perché quel ceto medio borghese dovrebbe rivelarsi oggettivamente più rivoluzionario del lavoro salariato? Non abbiamo nessuna ragione oggettiva per ritenerlo. Mi sembra, in tutta sincerità, uno “spostamento” arbitrario, dato da ragioni ideologiche, tutto sommato molto simile a quello operato dalla “sinistra” radicale (comunque neo liberale) che individua nelle donne (come se fossero un’unica categoria sociale con gli stessi interessi per il solo fatto di appartenere al genere femminile…) o nelle comunità lgbt il nuovo soggetto rivoluzionario. In fondo la stessa operazione che hanno fatto i post-neo-operaisti come Negri e Bifo che hanno spostato l’attenzione dalla classe operaia (che lo stesso Bifo ha definito “nazificata” in un convegno a Roma tre anni fa in occasione del centenario della rivoluzione d’Ottobre, e quindi persa ad ogni ipotesi di trasformazione…viene allora da chiedersi perché si dichiari ancora comunista…) ai lavoratori cosiddetti “cognitivi” della Silicon Valley, individuati come il nuovo soggetto rivoluzionario. Diciamo che il metodo è più o meno lo stesso, cambiano solo i soggetti di riferimento. L’ipotesi di lavoro formulata da Melegari e Capoccetti parte metodologicamente dagli stessi presupposti ma va in una direzione neo-conservatrice (a differenza di quella di Negri e Bifo e di quella della “sinistra” radicale che secondo me è addirittura funzionale al capitale…).
La questione non è secondaria, quello che stiamo facendo non è un esercizio sociologico. Al contrario, si tratta di capire quali siano le contraddizione reali e i soggetti sociali che possono dare vita al processo di costruzione di quel blocco sociale di cui sopra. Mi pare, in franchezza, che la direzione tracciata da Melegari e Capoccetti rischia di andare inevitabilmente (anche se in assoluta buona fede) in tutt’altra direzione.